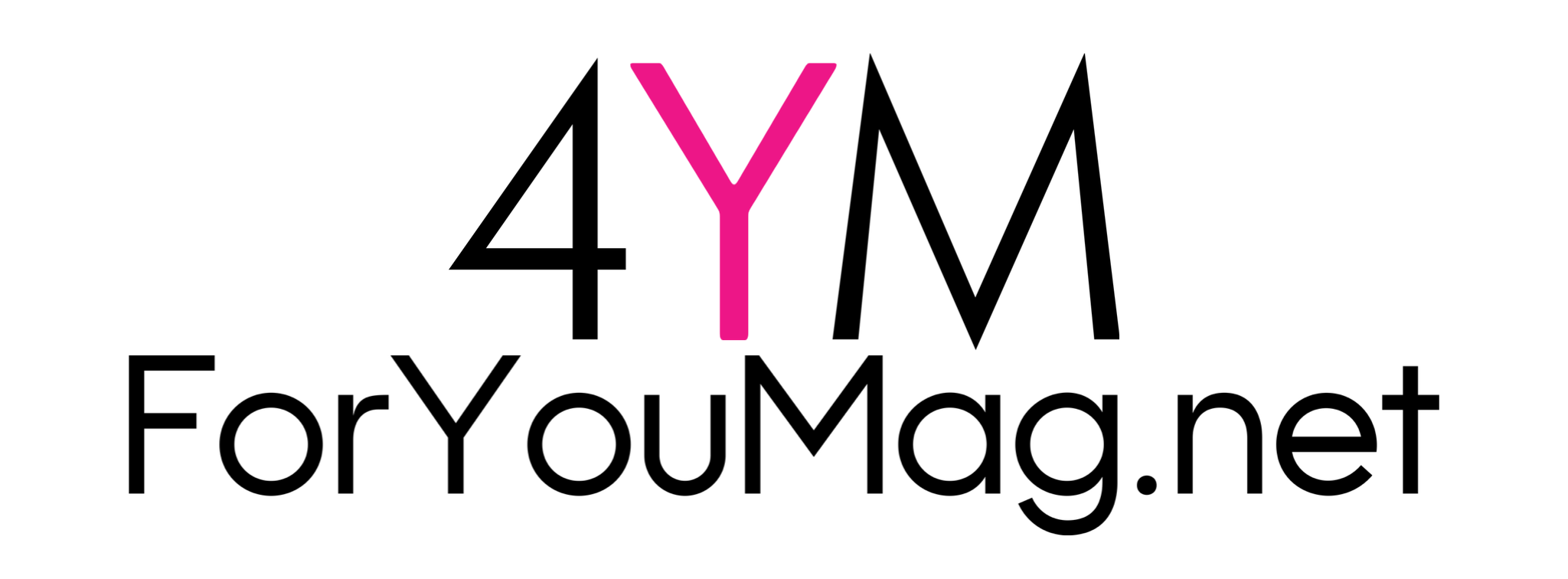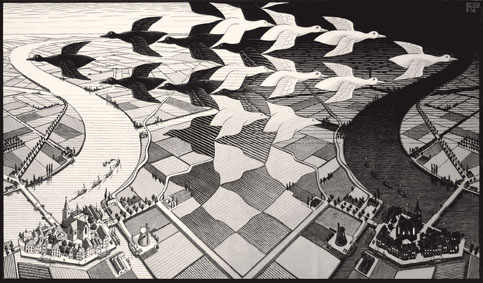“Convivium… sacrum humanitatis est.”
(Petronio, Satyricon, 47)
Il cibo, nell’antichità romana, non era solo nutrizione: era grammatica sociale, gerarchia simbolica, espressione concreta di un ordine cosmico interiorizzato. In questa prospettiva, la mostra Dall’uovo alle mele. La civiltà del cibo e i piaceri della tavola a Ercolano — ospitata a Villa Campolieto dal 28 marzo al 31 dicembre 2025 — va ben oltre il racconto didattico di una cultura alimentare perduta: essa si impone come spazio rivelatore, in cui la materia archeologica interagisce con l’architettura, la memoria e la coscienza del tempo.
L’allestimento, progettato con un’intelligenza scenografica che raramente si incontra nel panorama espositivo italiano, si articola come una “stanza nella stanza”: non invade, ma accoglie; non sovrappone, ma sottolinea. Le sale affrescate della vanvitelliana Villa Campolieto — opera emblematica del Miglio d’Oro — diventano esse stesse reperto e cassa armonica di una narrazione che intreccia oggetti, spazi, luci e vuoti. Il risultato è un percorso immersivo, dove ogni reperto — vasellame, resti organici, utensili — sembra affiorare non dal suolo, ma dalla mente.
Qui l’archeologia non si limita a esporre: evoca. Ed evoca una Roma che sapeva fare del pasto un rito, del gesto della preparazione una liturgia domestica, dell’ospitalità una virtù sociale. Plinio il Vecchio, nel Naturalis Historia, racconta dell’incredibile varietà di frutti, ortaggi e spezie che giungevano sulle tavole romane: «omnia quae terra gignit, ut apta sint cibo, sunt cura et arte melius reddita». Nulla si dava per scontato: la natura era potenziata dalla tecnica, e la tecnica dall’arte del vivere.
I resti carbonizzati di pane, fichi, olive, legumi, uova, pesci, frutti di mare, formaggi — ritrovati nelle case di Ercolano — non sono soltanto tracce di vita interrotta, ma reperti del quotidiano, in cui si riflette l’intero sistema simbolico di una civiltà. Apicio, nel De re coquinaria, codificava questa arte gastronomica in ricette che rivelano il gusto per l’equilibrio e l’opulenza: dalla patina de piris (una torta di pere) al moretum (un condimento a base di formaggio, erbe e aglio pestati nel mortaio), emerge una cultura culinaria consapevole, raffinata, stratificata.
L’esposizione si arricchisce di strumenti della preparazione — grattugie, paioli, cucchiai, colini, formelle per il pane — che ci riportano al tempo lento delle cucine romane, spesso collocate nei retrobottega o nei livelli seminterrati delle domus. In quei gesti umili, tramandati nel silenzio di mani femminili e schiave esperte, si giocava la qualità di un pasto e la reputazione del padrone di casa. Orazio, con il suo consueto disincanto, ci offre una sintesi lapidaria: “Nil sine magno vita labore dedit mortalibus” (Epistole, I.10.24) — nulla senza grande fatica è dato agli uomini, neppure il piacere della tavola.
L’intelligenza curatoriale della mostra risiede anche nel suo impianto narrativo, che non procede per generi alimentari, ma per spazi, funzioni e significati. Gli scheletri ritrovati sulla spiaggia, oltre 300 vittime dell’eruzione, restituiscono non solo biografie ma diete. Grazie all’archeometria e allo studio dei residui nei denti e nelle ossa, possiamo oggi conoscere le abitudini alimentari di quelle persone — donne, uomini e bambini — che vissero e morirono ad Ercolano. Non si tratta più di astrazione accademica: queste vite si affacciano al presente, ci interpellano, ci somigliano.
La mostra conclude un percorso iniziato anni fa, nel progetto “Ercolano 1738–2018. Talento, passato e presente”, che ha restituito il valore estetico e documentario degli ori, del legno e ora del cibo. Il ciclo si chiude simbolicamente qui, in una villa del Settecento, quasi a indicare la continuità tra l’antico e l’età della riscoperta borbonica. Ma più ancora, il cibo diventa ponte tra passato e futuro: perché, come scrive Columella nel De re rustica, “fructus terrae sine cultura nullus est” — il frutto della terra non nasce senza cura. E la cultura, oggi, ha bisogno di queste radici per dare nuovi frutti.
Dall’uovo alle mele è dunque una mostra che pensa, educa, e soprattutto interroga. Dove sono oggi le nostre cucine? Dove la nostra attenzione alla qualità, alla provenienza, alla forma della condivisione? In una società che rischia di dimenticare il senso del limite, della misura e della stagionalità, l’alimentazione romana diventa specchio e monito. Ci ricorda che mangiare bene non è un lusso, ma un esercizio di civiltà.
E se ogni banchetto romano cominciava con le uova e terminava con le mele, questo percorso inizia con la materia e termina nella coscienza.