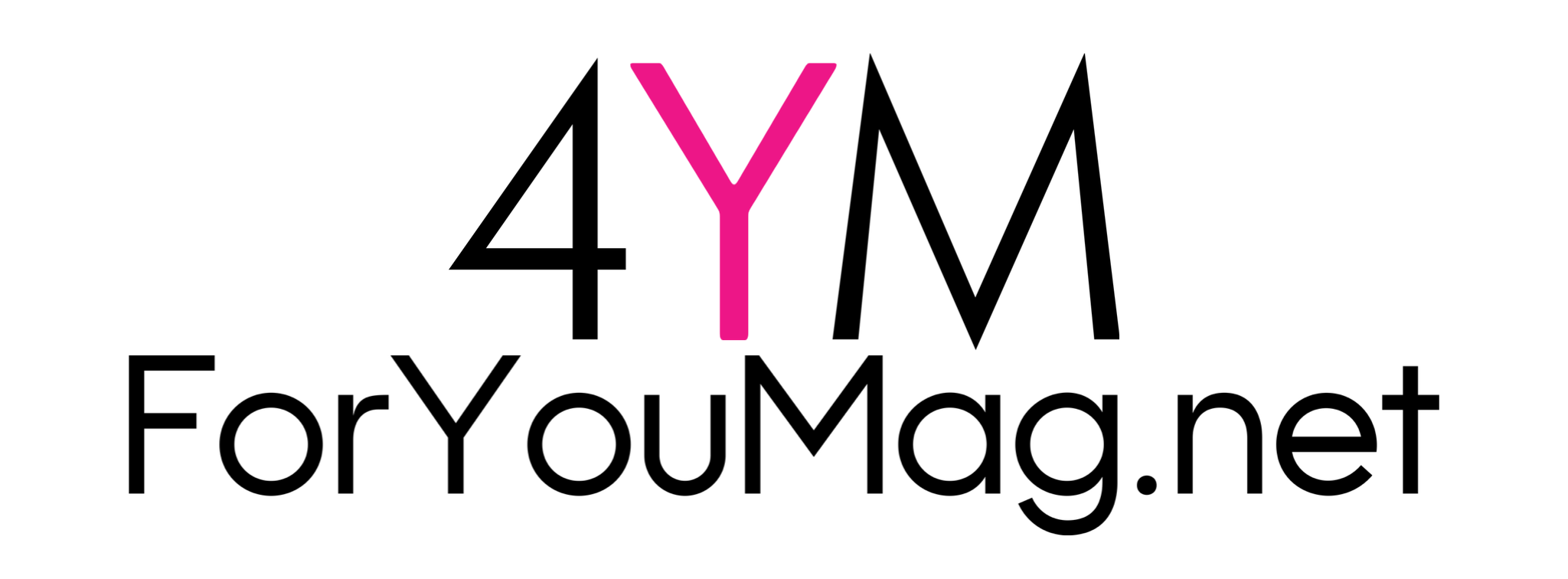Ai Musei di San Salvatore in Lauro, fino al 15 giugno, una mostra acuta e necessaria ripercorre il canto crepuscolare della grande tradizione xilografica giapponese nel XX secolo, tra echi d’Oriente e sguardi rivolti a Occidente.
Non è mai facile osservare un’arte al tramonto, soprattutto quando ha conosciuto vertici altissimi di coerenza formale e rigore tecnico. Ma è proprio in quel momento, quando l’onda si ritrae, che si rivelano spesso le tensioni più sottili, le intelligenze più discrete. La mostra Gli Shinhanga. Una rivoluzione nelle stampe giapponesi, ospitata ai Musei di San Salvatore in Lauro fino al 15 giugno, si presenta come un esercizio critico sulla sopravvivenza e sulla trasformazione di una forma artistica che, per secoli, ha costituito uno dei capolavori assoluti della cultura figurativa asiatica: la stampa su legno giapponese, o ukiyo-e.
Ora, è bene sgombrare subito il campo da ogni romanticismo di maniera. La mostra non documenta una rivoluzione — come ammicca il titolo — bensì una riflessione tardonovecentesca su una civiltà figurativa in declino. Lo Shinhanga, che significa “nuove stampe”, non rappresenta tanto un punto di rottura quanto un raffinato tentativo di sopravvivenza. Un compromesso, se vogliamo, tra l’urgenza dell’Occidente moderno e il peso di un passato troppo glorioso per essere abbandonato senza rimpianto.
Nato per iniziativa di un editore — Watanabe Shōzaburō, figura astuta e lungimirante, ma per nulla disinteressata — il movimento prende forma nei primi anni del Novecento, in un Giappone già occidentalizzato nella struttura sociale, ma ancora profondamente legato alla propria immaginazione culturale. È proprio Watanabe a comprendere che l’antica tradizione dell’ukiyo-e, esaurita nei suoi contenuti popolari e nelle sue icone teatrali, poteva essere “rifunzionalizzata” per un nuovo pubblico: colto, straniero, nostalgico di un Oriente ormai esotico e trasfigurato.
Il risultato è un corpus di opere raffinatissime, eseguite secondo i canoni tecnici dell’arte xilografica — quindi con disegno, incisione e stampa affidati a mani diverse, come da consuetudine — ma reinterpretate alla luce della sensibilità tardo-impressionista e simbolista. Le opere esposte, oltre 120, provengono da collezioni private e dalla Japanese Gallery Kensington di Londra. Ciò che vediamo, dunque, non è tanto il Giappone del XX secolo, quanto la sua proiezione estetica destinata a un pubblico internazionale. Un Giappone riflesso, più che rappresentato.
E tuttavia, ciò non toglie nulla alla qualità formale delle opere. Kawase Hasui, Itō Shinsui, Hashiguchi Goyō sono nomi che, pur non essendo innovatori in senso stretto, hanno saputo mantenere livelli altissimi di coerenza linguistica. I paesaggi di Hasui, in particolare, si distinguono per una delicatezza tonale che nulla ha da invidiare agli acquerelli inglesi dell’Ottocento. Il suo uso della luce, la morbidezza delle atmosfere invernali o notturne, la composizione calibrata ma mai rigida, testimoniano una consapevolezza tecnica notevole.
Lo stesso vale per i bijinga (ritratti di donne) di Itō Shinsui: immagini costruite su equilibri fragili tra idealizzazione e osservazione, in cui l’anatomia femminile è trattata con una misura quasi calligrafica, senza mai sconfinare nella caricatura erotica che aveva afflitto molte stampe dell’ultimo ukiyo-e. Goyō, dal canto suo, restituisce il corpo e il gesto con una sobrietà tutta interiore, come se cercasse nella superficie dell’immagine una memoria di qualcosa che non può più essere realmente vissuto.
Dal punto di vista storico-critico, la mostra ha il merito di contestualizzare la produzione dello Shinhanga all’interno di un’epoca di profonde trasformazioni: l’arrivo della fotografia, il declino dell’artigianato, la trasformazione dell’arte in bene da esportazione. In effetti, gran parte delle opere vennero realizzate per il mercato occidentale: tirature limitate, carta di pregio, soggetti facilmente leggibili anche da un occhio non giapponese. Questo doppio sguardo — uno interno, nostalgico; l’altro esterno, collezionistico — è l’aspetto più interessante dell’operazione.
L’allestimento non indulge a trovate spettacolari. Le stampe sono esposte con sobrietà, accompagnate da apparati didattici chiari ma non invadenti. Un’intera sezione è dedicata ai materiali e alle tecniche: le matrici in legno, gli inchiostri, le fasi della stampa. Una scelta importante, perché proprio nella lavorazione materiale dello Shinhanga si nasconde la sua identità più autentica: un sapere collettivo, stratificato, profondamente artigianale, che contrasta con l’individualismo dell’artista occidentale moderno.
Sono esposte anche fotografie d’epoca, kimono, oggetti di uso quotidiano, che ricostruiscono il contesto della produzione. Ma ciò che colpisce davvero è il silenzio che queste immagini impongono. Lo Shinhanga è arte del silenzio e del tempo lungo. Ogni foglio è il risultato di un processo misurato, ripetuto, calibrato fino all’estremo. In questo, si rivela come un’arte profondamente reazionaria: non accetta la velocità del nuovo mondo, ma la rifiuta con eleganza. Si affida alla memoria, alla compostezza, al gesto lento.
È difficile dire se questa sia una “rivoluzione”, come recita il titolo. A mio avviso, si tratta piuttosto di un epilogo consapevole. Lo Shinhanga non cambia la storia dell’arte giapponese, ma la chiude con grazia. È il crepuscolo dell’ukiyo-e, e come tutti i crepuscoli, ha colori più intensi del giorno. Ma è pur sempre un tramonto.
Eppure, proprio per questo, merita attenzione. In tempi di immagini prodotte in serie, di estetiche liquide, di cultura dell’istantaneo, queste stampe ci ricordano che esiste ancora — o che almeno è esistita — un’arte capace di sintesi, misura, e soprattutto di pudore.
Si esce dalla mostra non stupiti, non abbagliati. Ma più silenziosi. E forse un po’ più consapevoli del fatto che anche l’arte, come ogni civiltà, ha bisogno di saper morire con dignità. Lo Shinhanga ce lo insegna con ogni linea, ogni sfumatura, ogni gesto inciso su carta.
E questo, in un mondo che confonde troppo facilmente la novità con il valore, è già una lezione preziosa.