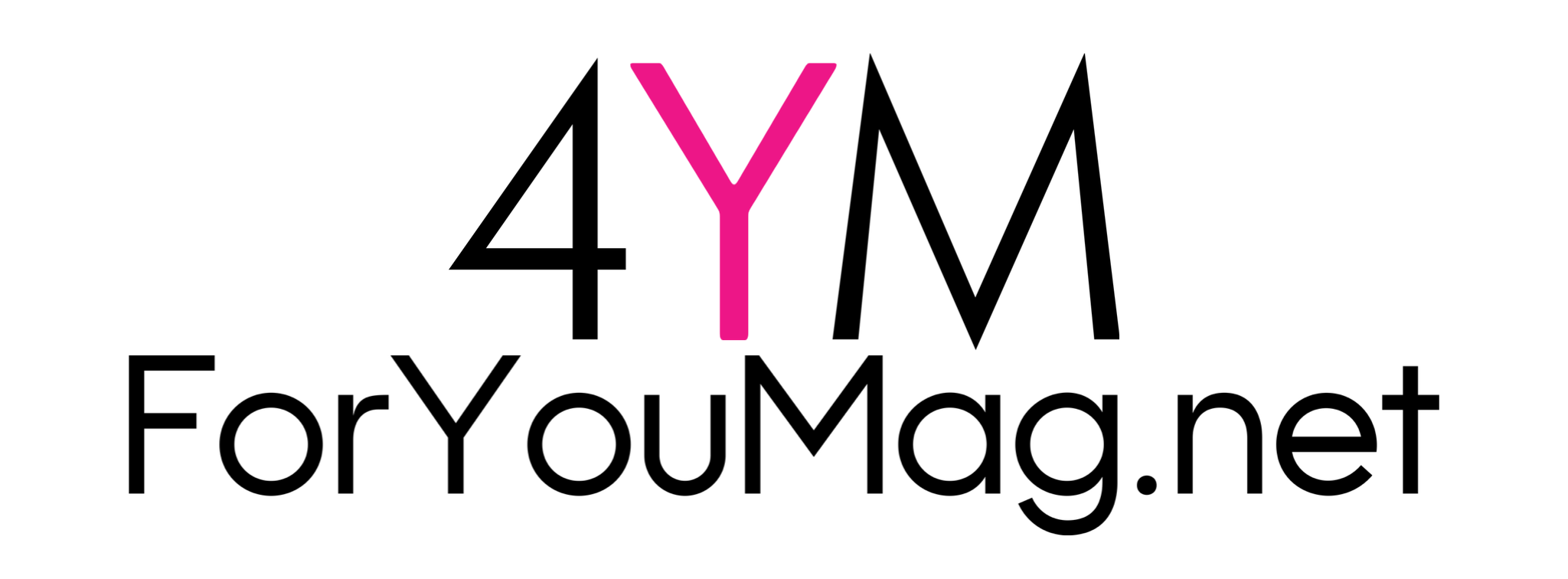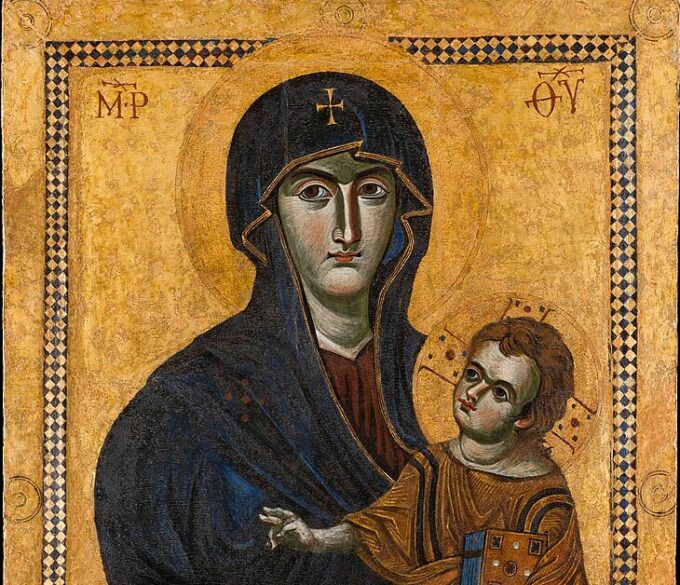Nel cuore silenzioso e austero del Palatino, là dove le pietre conservano la voce delle civiltà, Brancusi: scolpire il volo si rivela come una meditazione sull’essenza della forma, sul desiderio umano di elevarsi oltre i limiti della materia. Per la prima volta a Roma, alcune tra le più emblematiche opere dello scultore romeno naturalizzato francese trovano posto in una mostra che non è solo esposizione, ma rito laico di contemplazione. Organizzata dal Parco Archeologico del Colosseo in co-organizzazione con il Centre National d’art et de la culture Georges Pompidou di Parigi, l’esposizione – visitabile fino a domenica 11 maggio – invita il pubblico a scoprire il linguaggio essenziale e simbolico di Constantin Brancusi, tra i più geniali artefici della scultura moderna.

Artista visionario, Brancusi ha riscritto il vocabolario plastico del Novecento con gesti semplici e radicali. Nato in Romania nel 1876, cresciuto tra le tradizioni arcaiche dei Carpazi e approdato a Parigi, seppe fondere l’eredità del mondo contadino con il rigore concettuale delle avanguardie. Nelle sue mani, il marmo, il bronzo e il legno non erano meri materiali, ma essenze da liberare, da ascoltare. Con una vera rivoluzione del gesto, Brancusi abbandonò la tecnica del modellato per scegliere l’intaglio diretto: scavare, togliere, snidare dal cuore della materia la forma nascosta. In questo atto radicale, vi era un’affinità con l’alchimia e con la spiritualità delle origini. La sua scultura non rappresenta: evoca. Non descrive: incarna.
Le Uccelliere Farnesiane sul colle Palatino, luogo simbolo riscoperto alla fine del Settecento dai viaggiatori del Grand Tour, diventano così scenografia perfetta per un percorso dedicato a uno dei temi centrali dell’opera di Brancusi: il bestiario degli uccelli. Due gli ambienti della struttura farnesiana che accolgono la mostra, curata da Alfonsina Russo, Philippe-Alain Michaud, Maria Laura Cavaliere e Daniele Fortuna. Il primo spazio è dedicato alla scultura: qui il visitatore incontra Il Gallo (Le Coq, 1935), L’Uccellino (L’Oiselet, 1928) e Leda (1920/1926 circa), opere emblematiche della sua poetica. Il dettaglio è bandito, la forma è distillata, pura, simbolica. Come Brancusi stesso affermava: “Non è l’uccello che voglio rappresentare, ma il dono, il volo, lo slancio”.
Queste figure, che sembrano provenire da un altrove remoto e immobile, dialogano in mostra con una selezione di sculture antiche che arricchiscono l’esposizione: statue, balsamari, are e sonagli di epoca romana, provenienti dal Museo Nazionale Romano, dal Museo Archeologico di Venezia e dal Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. In questo confronto, non cronologico ma spirituale, si rivela il legame profondo tra le culture antiche e la visione di Brancusi: gli uccelli, animali sacri e intermediari tra l’umano e il divino, sono qui portatori di messaggi ultraterreni, simboli di un anelito che è sogno e bisogno. Il volo diventa l’immagine dell’ascensione, del superamento del confine, della tensione dell’uomo verso l’infinito.

La seconda sezione dell’esposizione svela un altro aspetto, meno noto ma altrettanto raffinato, della ricerca di Brancusi: l’utilizzo della fotografia e del cinema. Negli anni Venti e Trenta, lo scultore si avvicina a questi nuovi linguaggi per indagare non solo l’immagine delle sue opere, ma la loro relazione con la luce, il tempo, il movimento. Per lui la fotografia non era uno strumento passivo di registrazione, ma una vera forma d’arte, capace di restituire l’effimero, l’invisibile, l’irraggiungibile. Emblematico è il film Leda in movimento del 1936, in cui la scultura è posta su un disco rotante in acciaio lucido: un lago di luce in cui l’opera si riflette, si moltiplica, si trasfigura.
L’allestimento, firmato dall’architetto Dolores Lettieri, esalta con eleganza la duplice anima della mostra, giocando sulla dicotomia tra il bianco – colore dell’atelier di Brancusi, spazio della creazione – e il nero – richiamo alla camera oscura, alla fotografia come rivelazione alchemica. Il risultato è un equilibrio raffinato tra contemplazione e racconto, tra forma e visione.

A completare il progetto, è in arrivo a fine marzo Brancusi, volume edito da Electa, che raccoglie saggi critici e approfondimenti, colmando una storica lacuna nel panorama editoriale italiano. Il Parco Archeologico del Colosseo, Electa e la Fondazione Fondamenta accompagneranno inoltre la mostra con un ricco programma culturale fino a ottobre, ospitato nella Curia Iulia e in altri luoghi del Foro Romano, dal titolo evocativo Il futuro ha un cuore antico, omaggio a Carlo Levi, di cui ricorre quest’anno il cinquantenario della morte.
Brancusi: scolpire il volo è dunque molto più di un evento espositivo. È un invito a salire, a guardare le cose dall’alto, a riconoscere, nelle curve di una scultura, il battito del cielo. In un’epoca in cui tutto si consuma in fretta, questa mostra ci restituisce il senso della durata, della verticalità, dell’essenziale. E ci ricorda che il volo più audace non è quello degli uccelli, ma quello dell’anima che sa riconoscere nella forma il suo destino.