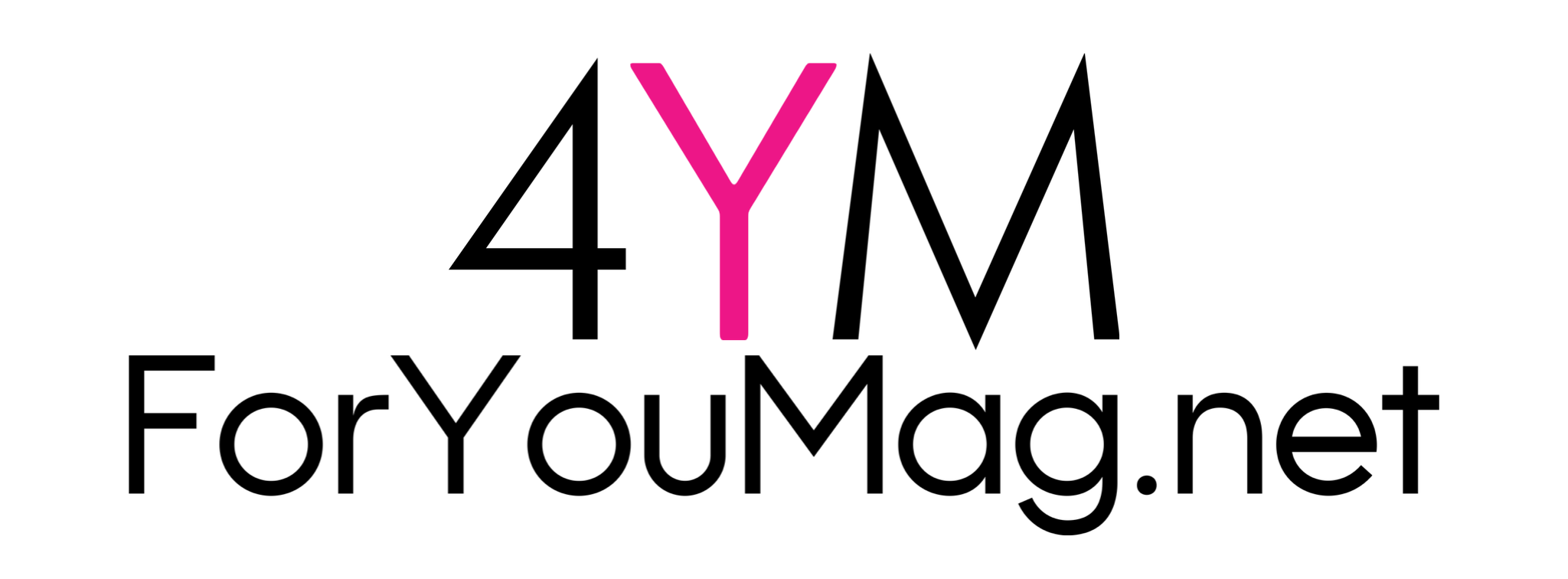“Dear Son” di Simone Repele e Sasha Riva incanta con la sua atmosfera raccolta, fondendo neoclassicismo e danza contemporanea per raccontare le emozioni delicate di una lettera di una madre al figlio perduto in guerra, lasciando un’impronta profonda nel pubblico della Sala Petrassi, Auditorium Parco della Musica.
In un panorama di spettacoli di danza che si sono susseguiti quest’anno al Romaeuropa Festival, “Dear Son” emerge come un’opera intima e drammatica, quasi distaccata per la sua atmosfera peculiare. Presentato nella Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica, il lavoro di Simone Repele e Sasha Riva ha suscitato un’impressione profonda per il suo carattere raccolto e la sua intensa introspezione. I due coreografi, artisti di rilievo sulla scena contemporanea, vantano una carriera luminosa presso il Balletto di Amburgo e il Balletto di Ginevra, oltre alla fondazione della loro compagnia nel 2020, divenuta immediatamente riconoscibile per una sensibilità poetica e teatrale che ha attraversato ogni loro creazione, a partire da “Lili Elbe Show”. La loro cifra stilistica è una fusione armoniosa tra neoclassicismo e contemporaneità, in cui la danza si esprime con una forza figurativa che attinge tanto al rigore accademico quanto alla freschezza innovativa.

Già alcuni mesi fa, nella stagione del Teatro dell’Opera di Roma, avevamo ammirato l’opera di Repele e Riva con “I Died for Love”, una creazione capace di infondere leggerezza e una certa giocosità persino al tema della morte per amore, trattato con grazia e ironia, trasporsi nella quotidianità contemporanea. Allora, il dialogo con il corpo di ballo del teatro, le scene di Michele Della Cioppa e i costumi di Anna Biagiotti avevano arricchito la composizione, rendendo la narrazione vivida e stratificata. Ora, in occasione di Romaeuropa, ci troviamo di fronte a un’opera dalle dimensioni più intime, che si affida principalmente alla presenza scenica degli interpreti, un trio formato dagli stessi Repele e Riva, affiancati dalla magnetica Anne Jung. La scena è volutamente spoglia, ridotta all’essenziale, creando un contesto in cui luci e musiche diventano elementi determinanti nel tessere la narrazione.
Le luci di Alessandro Caso accompagnano i momenti salienti con una sapiente alternanza di chiaroscuri e di ombre soffuse, che riescono a sottolineare i passaggi emotivi più intensi. L’inizio è segnato da suoni elettronici che riecheggiano nel buio, mentre i danzatori giacciono a terra, un’immagine che evoca con forza il tema della guerra. Successivamente, la scena si fa più raccolta: un piccolo tavolino, una luce calda e morbida, una donna di spalle che osserva una fotografia. Questa immagine introduce il tema del ricordo, con una serie di flashback che uniscono passato, presente e futuro. La guerra torna, ma in chiave ironica, con le strofe di “Bella ciao” a riecheggiare la Resistenza, un richiamo alle origini torinesi di Simone Repele e all’ambiente in cui lo spettacolo ha preso forma, la Fondazione Orsolina 28 a Moncalvo.
Le scelte musicali spaziano dalla musica leggera italiana, che apporta un tocco vintage, a brani contemporanei, creando un tessuto sonoro che ben si presta all’alternarsi dei vari sfasamenti temporali della narrazione. “Il cielo in una stanza” di Gino Paoli emerge come un momento lirico particolarmente evocativo, capace di comunicare l’assenza di peso del tema affrontato. “Dear Son” è, infatti, la lettera di una madre al figlio perduto in guerra, un’esperienza di dolore indicibile, mitigato tuttavia dalla dolcezza dei ricordi: l’attesa, i primi momenti d’amore, la gioia di una famiglia unita. La danza si fa linguaggio potente, con passi a due di grande intensità che esplorano la dimensione affettiva e la potenza dei sentimenti osservati dall’esterno, mantenendo un costante equilibrio tra neoclassicismo e modernità.

Il corpo diviene il mezzo attraverso cui si esprime il vissuto: i gesti e le espressioni, pur calcati, non risultano mai eccessivi, bensì funzionali a fissare frammenti di vita che appaiono, e forse devono apparire, distanti, come un ricordo che si sbiadisce ma non si spegne mai del tutto. I quadri coreografici si susseguono con fluidità, senza appesantire lo spettatore, che talvolta potrebbe desiderare maggiore consistenza drammaturgica, ma che resta comunque coinvolto dall’intensità delle emozioni evocate. Lo sbriciolarsi della farina – un’immagine simbolica che richiama tanto la guerra quanto la vecchiaia, la perdita della vitalità – segna uno dei momenti più poetici della performance.
Lo spettacolo si conclude con i delicati disegni di Gu Jiajun, un tocco finale che suggella la continuità del legame familiare, che va oltre il tempo e lo spazio, oltre la vita e la morte. “Dear Son” è, a suo modo, un’opera di nicchia, che si inserisce in modo peculiare nella programmazione di Romaeuropa, meno spettacolare forse rispetto ad altri lavori, ma profondamente incisiva nella sua drammaticità ispirata. Una rappresentazione che, nella sua semplicità e nella sua essenzialità, riesce a toccare corde profonde, lasciando un segno intimo e durevole. Foto di Angelina Bertrand.