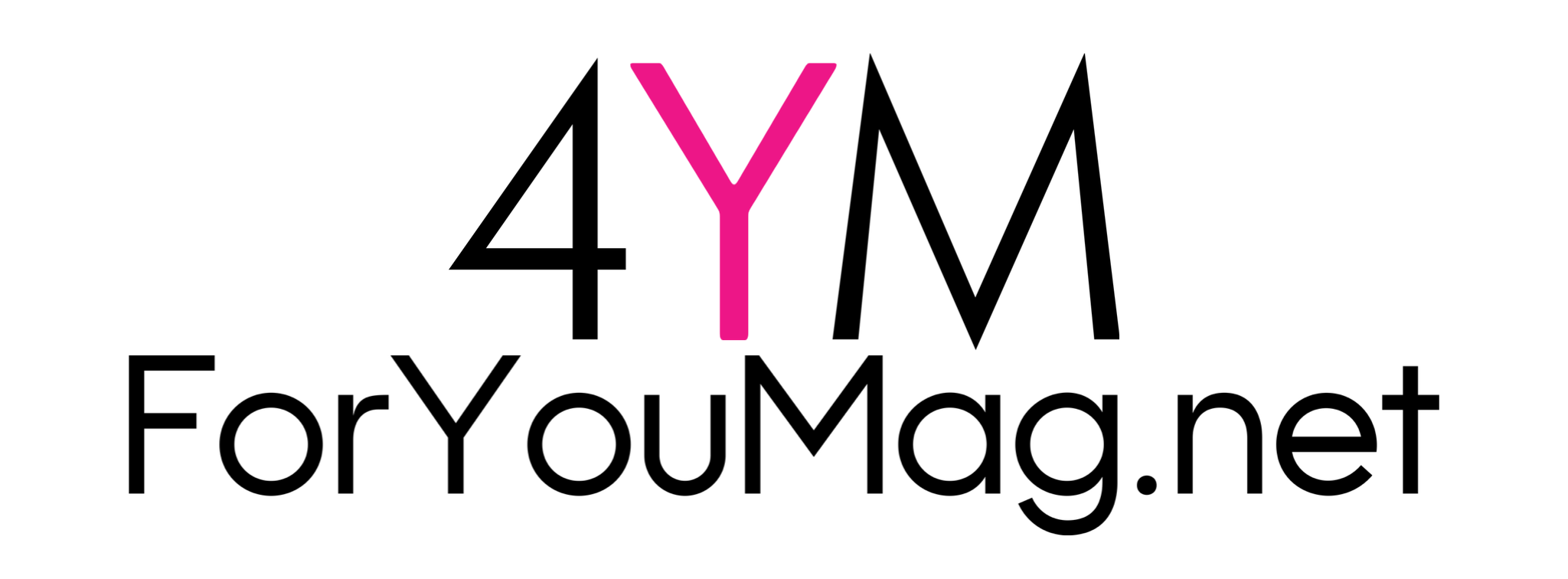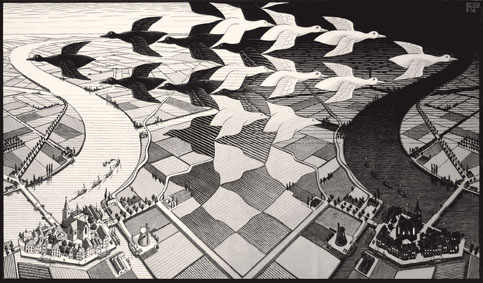Disperso per secoli, occultato da ridipinture e dimenticanze, il capolavoro della «Deposizione di Cristo» riemerge dal Santuario di Pompei. Un restauro magistrale ne rivela l’autenticità e il genio: dal 20 marzo in mostra ai Musei Vaticani.
Una scoperta che squassa le fondamenta della storia dell’arte. Non è un semplice ritrovamento, ma un risarcimento culturale: il ritorno della mano divina di Andrea Mantegna a squarciare il velo del tempo, ricucendo le maglie della storia. Una “Deposizione di Cristo” finora avvolta in una coltre di discrezione devozionale, ospitata nel Santuario della Beata Vergine del Rosario a Pompei, si svela oggi nella sua autenticità di pennello mantegnesco. Un’apparizione che pone domande, dilata le certezze e ridefinisce i margini della geografia artistica italiana.
Il Mantegna pompeiano emerge da una palude di attribuzioni sfuggenti e, grazie a un restauro che è stato un’operazione di archeologia pittorica, si ricongiunge alla gloria che gli spetta. È la storia di un dipinto che, per oltre un secolo, ha vegliato nel silenzio di un luogo sacro, ignorato dagli storici d’arte e sommerso dall’anonimato popolare. Solo l’occhio avvertito del restauro ha saputo strappare il velo che lo avvolgeva. La tela, dopo un lungo e meticoloso intervento conservativo iniziato nel marzo 2022, ha rivelato sotto le pesanti ridipinture ottocentesche la struttura adamantina e l’ossessione prospettica tipiche del maestro di Isola di Carturo.
Andrea Mantegna, spirito d’acciaio e pennello di pietra, il pittore che scolpiva con la tempera su tela, ritorna come un revenant tra i marmi caduchi di Pompei. La sua “Deposizione di Cristo” si impone come un apparato scultoreo, un teatro della passione umana che travalica la cronaca biblica per farsi architettura sentimentale e spazio concettuale. Un ritorno dell’antico non per mera nostalgia, ma per una rinnovata esigenza di classicità, un manierismo genetico che affiora quando il linguaggio contemporaneo sente il bisogno di radici profonde. L’attribuzione di quest’opera a Mantegna non è solo un fatto di stile, ma un evento teorico. Siamo nel cuore di una ridefinizione dell’identità artistica, laddove il concetto di auraticità si fonde con il principio dell’eterna ricorrenza dell’opera d’arte come organismo vivo. La “Deposizione” pompeiana non è un reperto, ma un virus concettuale che infetta il sistema dell’arte, imponendo una riscrittura critica del catalogo mantegnesco e, per estensione, della cultura figurativa del Quattrocento.
Lo spettatore è chiamato a un rito iniziatico: penetrare la geometria ferrea del disegno mantegnesco, quell’ordine costruttivo che è misura e tortura, razionalità e dramma. Cristo è deposto, ma mai abbandonato; le membra contratte denunciano la sofferenza come cifra geometrica, e i personaggi che lo circondano partecipano al dramma non con pathos urlato, ma con la compostezza di una tragedia greca. È l’arte come ordine morale, dove la luce incide come un bisturi e la composizione è architettura d’anime.
Questa scoperta apre la strada a una riflessione più ampia. Perché Pompei? Perché una tela del Mantegna qui, ai margini estremi del Rinascimento padano? La risposta è nella natura stessa del Sud, come territorio dell’epifania e del ritorno. Non è la prima volta che il Meridione si fa crocevia di un’arte che non si limita alla geografia dei centri di potere, ma si irradia lungo rotte sotterranee, dove il culto e la committenza privata diventano vettori di contaminazione. Pompei, città di morte e di resurrezione per antonomasia, accoglie ora l’ennesimo paradosso: un Rinascimento che si fa reliquia, non per fossilizzarsi, ma per tornare attivo, performativo, capace di destabilizzare le cronologie canoniche. Il classico non cessa di ritornare perché necessario alla modernità.
Mantegna non è mai stato un artista semplice. Il suo classicismo è violento, la sua bellezza è scabrosa. La “Deposizione” di Pompei conserva questa cifra: la composizione è una macchina da guerra, un impianto scenografico che strappa la visione all’incanto devozionale per restituirla alla crudeltà della forma. La carne è pietra, il dolore è proporzione. E in tutto questo si sente la lezione appresa da Mantegna durante il suo soggiorno romano, quando contemplava i sarcofagi e le rovine come atlanti del corpo e della psiche.
Era dato per disperso, introvabile dopo essere scomparso dalla basilica di San Domenico Maggiore a Napoli. E invece era semplicemente nascosto dietro l’angolo, nel Santuario di Pompei, sotto strati di ridipinture. È Il Mattino a dare per primo la notizia del tesoro nascosto, un quadro di inestimabile valore del pittore Andrea Mantegna che ritrae la “Deposizione di Cristo”. Un’attribuzione ora confermata ufficialmente anche dal Vaticano, tanto che già questo giovedì – 20 marzo – l’opera sarà esposta ai Musei Vaticani all’interno della mostra “Il Mantegna di Pompei. Un capolavoro ritrovato”, dedicata al pittore veneto del XV secolo e che avrà come piatto forte proprio la tela pompeiana. A chiarire tutto, o quasi, è stato il restauro dei maestri vaticani, che ha permesso di restituire alla comunità scientifica e al pubblico un’opera rimasta per secoli avvolta nel mistero e oggi tornata alla luce nella sua piena autenticità. Il primo riconoscimento, dopo la convocazione da parte dell’arcivescovo prelato di Pompei Tommaso Caputo, è avvenuto nel marzo 2022. Al resto ci ha pensato il restauro che, sotto vari strati di pitture successive, ha rivelato dettagli iconografici e tecnici che confermano l’autografia di Mantegna, restituendo alla storia un capolavoro che si pensava perduto, ha spiegato la direttrice dei Musei Vaticani, Barbara Jatta. Un progetto lungo e complesso che ha visto il coinvolgimento di grandi nomi della storia dell’arte, come Gabriel Zuchtriegel, direttore del parco archeologico di Pompei, e Luigi Gallo, direttore regionale Musei delle Marche. E sull’originalità della tela non c’è più alcun dubbio.
Non tutto, però, è ancora stato chiarito. Non si sa quando la tela sia stata portata via dalla basilica napoletana e quando o come sia finita a Pompei. Si sa che da qualche anno era nel Santuario della città, tanto che la sua immagine era stata inserita nel sito della Conferenza episcopale italiana. Proprio da questo scatto è partita l’intuizione di Stefano De Mieri, ricercatore del Suor Orsola Benincasa, che ha collegato quelle figure al dipinto del Polittico di Angri, al centro del quale c’è una copia fedele della “Deposizione” di Mantegna, presunta dispersa e ora ritrovata.
L’opera è esposta per tre mesi nella Pinacoteca Vaticana, nella Sala XVII, accanto ai grandi maestri del Rinascimento. Non si tratta solo di una restituzione al pubblico, ma di un dispositivo critico: la tela di Pompei si misura con i giganti, non sfigura, ma rilancia. È una sfida: Mantegna parla ancora al presente, ricorda che l’arte non è solo decorazione, ma pensiero incarnato. Dopo il soggiorno vaticano, l’opera tornerà a Pompei, non più relegata in un altare secondario, ma al centro di un nuovo spazio espositivo allestito presso il Santuario. La “Deposizione” diventa così un’icona laica e religiosa insieme, un oggetto di culto e di studio, capace di attrarre tanto il pellegrino quanto lo storico dell’arte.
Un Mantegna a Pompei non è un evento chiuso. È un processo aperto, una contaminazione che ci obbliga a ripensare la mappa culturale italiana. L’artista classico è sempre un traditore del proprio tempo, perché anticipa, rompe, inventa. Mantegna è questo: un artista che riappare oggi perché ci serve, perché nel caos delle immagini contemporanee abbiamo bisogno di quella ferocia ordinatrice, di quella durezza che sa rendere la morte un principio d’ordine. La “Deposizione” di Pompei è un monito e un richiamo: ci ricorda che l’arte è sempre un ritorno, ma mai un ritorno innocente. E nella Pompei che fu sepolta e che sempre risorge, Mantegna ci parla di nuovo, e ci costringe ad ascoltare. Un classico che non consola, ma sveglia. Come dovrebbe essere sempre.